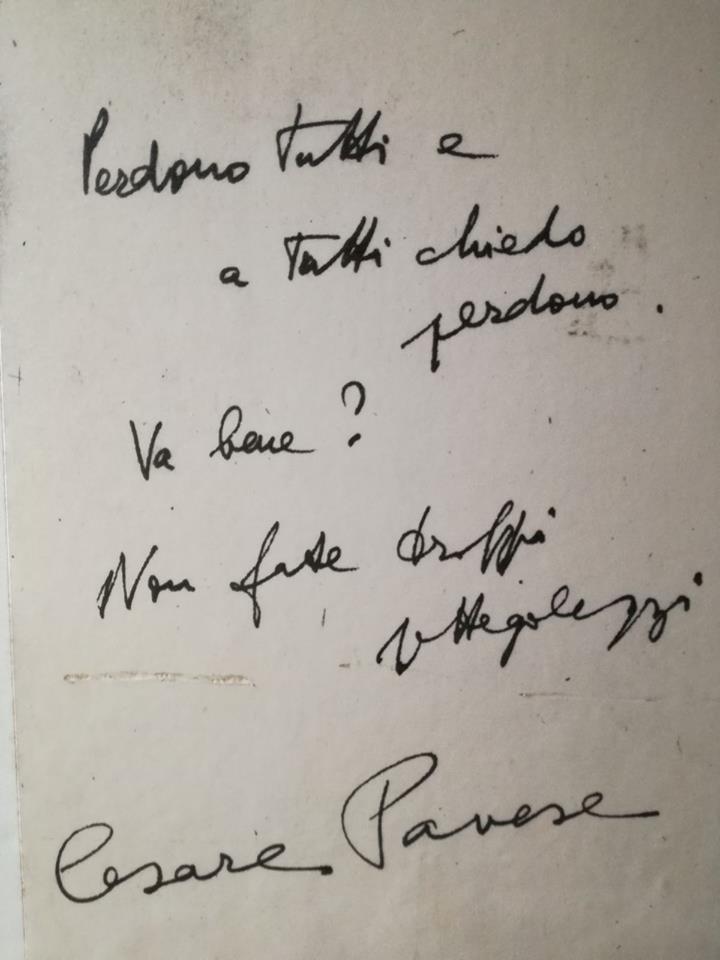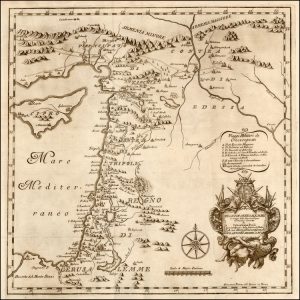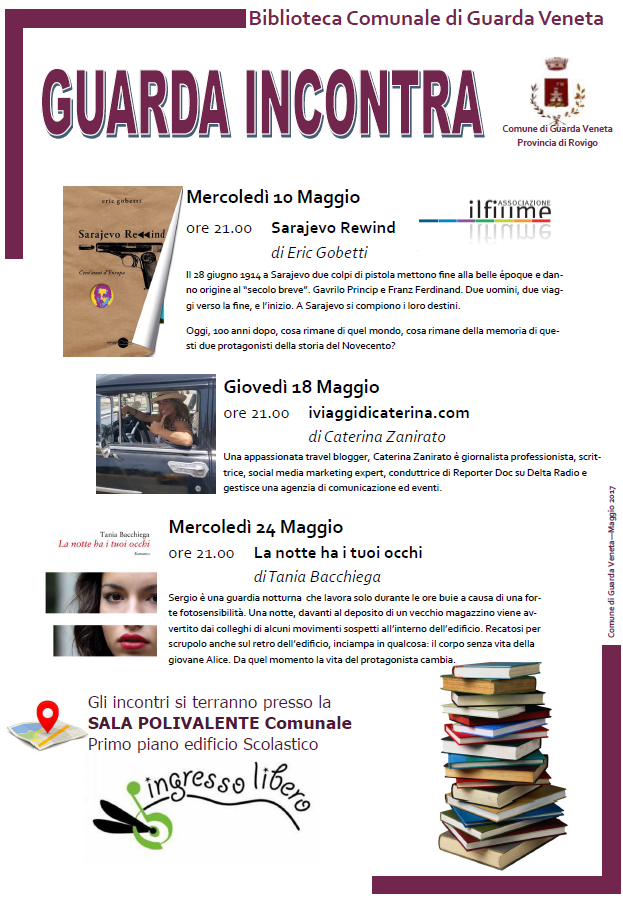Abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno narrazioni positive, abbiamo bisogno di resistenza a tutto il negativo del mondo, abbiamo bisogno di qualcuno che insegni al nostro paese le cose che contano. Abbiamo bisogno che i giovani imparino quel che è importante e quello che non lo è e dobbiamo usare tutti i mezzi per insegnarglielo. Credo che l’addio al calcio di Francesco Totti abbia insegnato molto a tanti giovani. Una cerimonia retorica ma solo poco poco, in compenso tanto ricca di momenti epici.
Il giro del campo in silenzio, retorica del gesto, forse, ma di sicuro disponibilità e offerta di sé a tutti i presenti per i quali c’è stato un saluto, una foto, un abbraccio, la firma di un pallone. La giusta lentezza a cui oggi non siamo più abituati. Tutto va veloce, lo spettacolo ha i suoi ritmi. Il giro di campo di Totti è stato giustamente un momento lento e solenne.
La musica, tanta e riconoscibile, dall’inno della Roma alla colonna sonora de “il Gladiatore” a “La vita è bella”. Musica che a tutti parlava in modo personale ma anche universale.
La famiglia accanto a sé. Bella, importante, quasi all’antica. Certo il campione ha sposato una soubrette (un tempo si chiamavano così) come tanti calciatori ma, a differenza di molti altri, con lei sola ha messo al mondo tre figli e li sta allevando tra uno strafalcione e l’altro nel suo italiano imperfetto, spesso sfruttato dalla pubblicità, ma genuino.
La lettera scritta in modo molto semplice che parte dall’umiltà del campione che confessa la sua unica abilità, “dare calci ad un pallone”, il lavoro che è anche un gioco, una delle cose bella della vita. La confessione di chi non sa fare molte cose, ma quelle poche le fa bene e soprattutto le fa per un pubblico, per una società, per una città ma anche per il resto del mondo che assiste allo spettacolo.
Parole semplici, ammissione di paura di un futuro in cui non è semplice reinventarsi per chi sa far bene quelle poche cose. Ringraziamento a tutti, familiari, società, compagni di squadra. Ventotto anni sono un quarto della vita di una persona, e spesi nel mondo del calcio professionistico di alto livello significano tantissimi soldi. Ventotto anni in parte spesi a surfare tra una squadra e l’altra, a passare dall’Europa al mondo emergente del calcio, come fanno in molti, avrebbero significato ancor più soldi, tanti più soldi!
La fedeltà: ma quanti soldi servono ad un uomo per vivere bene con una moglie e tre figli? Evidentemente quelli che Totti ha guadagnato senza tradire un pubblico, una città, una maglia, senza passare in un’altra squadra e segnare ai suoi ex-tifosi, sono abbastanza per far vivere tutti loro e per riuscire anche a distribuirne in beneficenza aiutando gli altri.
Riuscire a incidere per le sue tante doti positive nell’animo dei ragazzi che lo hanno ammirato da tifosi ma anche da tifosi della altre squadre, sarà un altro contributo che quest’uomo darà al nostro paese. Certo uomini così ce ne sono tanti e la maggior parte restano oscuri ma non è un motivo per denigrare questa uscita dal calcio e far finta che sia una delle tante passerelle che il calcio propone da parte di uno dei suoi “eroi” viziati. Non fosse altro per la misura delle parole e dei gesti. Niente interviste prima, niente urla sataniche di commentatori stupidi, niente discorsi lunghi. Già questo basterebbe se servisse da esempio anche a certa tv. Possiamo criticare tutto e tutti, del resto Falcone, Borsellino e gli altri “eroi” loro malgrado non sono immuni da critiche, ma se anche solo un ragazzino sarà ispirato da quel che di buono ha fatto Totti, sarà un bene per tutti noi, genitori, insegnanti, politici, ecc ecc Esser d’esempio finalmente, senza per forza dover morire, mi sembra una buona cosa.