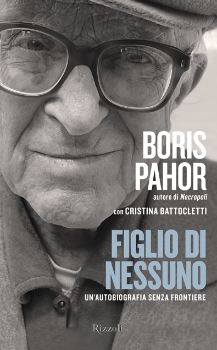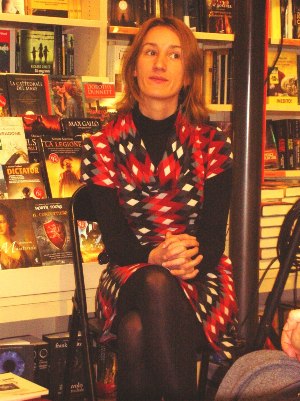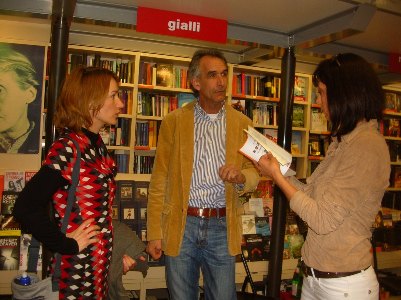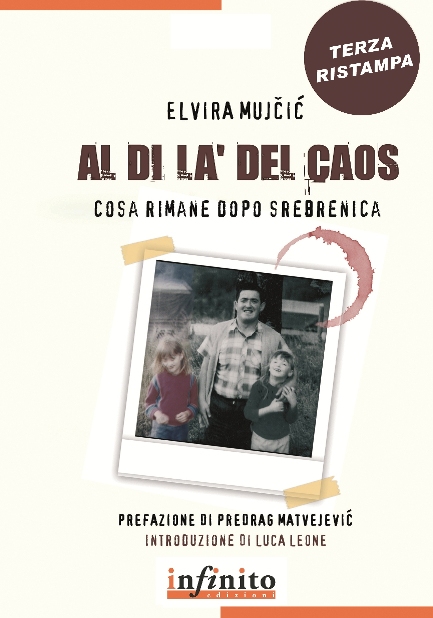Santino Spinelli sconosciuto ai più, come lo è il popolo Rom a cui appartiene, è docente universitario, scrittore e musicista raffinato e ha presentato il suo ultimo libro “Rom, genti libere” (Dalai Editore, 2012) in un doppio incontro, nella libreria “Sognalibro” di Ferrara e nella Sala Consigliare di Stienta (RO).
Con lui, a Ferrara, hanno dialogato il rabbino Luciano Caro che ha ammesso di non conoscere il popolo Rom, ma di saperlo molto simile al popolo ebraico per destino di migrazioni e persecuzioni, e il giovane storico Luca Bravi che da anni fa ricerca sul Porrajmos, ossia il nome che in lingua romanì si da alla shoah dei Rom.
Dagli incontri è emerso che non si parla mai della ricchezza culturale e degli aspetti positivi del popolo Rom, che viene identificato con l’eteronimo di “zingari” con tutti i riflessi negativi che il termine ha raccolto su di sé da secoli di persecuzioni.
Nel breve spazio che abbiamo, ci preme invertire la tendenza e rimandare alla lettura del libro di Santino Spinelli l’accurata ricostruzione storica sulle origini e le migrazioni del popolo Rom, per soffermarci su quanto di bello e ricco avrebbe da offrire la cultura Rom se solo qualcuno avesse l’intelligenza di chiederlo.
Per la loro origine orientale e indiana in particolare, i Rom non hanno una concezione del tempo da società industriale che lo parcellizza e divide secondo i tempi del lavoro, il loro tempo è diviso in giorno e notte, tempo dell’attività e del riposo. Tra i valori principali c’è quello della famiglia allargata che diventa un vero e proprio clan solidaristico in cui tutti contribuiscono per quel che possono a garantire il sostentamento dividendosi i compiti e soprattutto portando agli anziani il massimo rispetto. 
Un popolo che non ha mai dichiarato una guerra, che non ha rivendicato terre, seppur non rifiutando la stanzialità che la strumentale mitologia del mondo dei Gagi (gli altri, i non Rom) non riconosce possibile per i Rom. Un popolo pacifico che ha dovuto cambiare mestieri nel corso della storia per le evoluzioni della società industriale, ma che era portatore di grandi conoscenze ad esempio nell’allevamento e l’addestramento dei cavalli. Un popolo maestro nell’arte circense e soprattutto con una straordinaria conoscenza istintiva della musica che ha regalato al mondo sotto forma di flamenco e jazz e che ora, proprio grazie al lavoro di Santino Spinelli deve elaborare sotto forma sinfonica. Non a caso Spinelli è direttore dell’Orchestra Europea per la Pace che suona musiche definite dall’autore “etnosinfoniche”.
Genti libere, insomma, che hanno saputo mantenere un’identità che per gli altri è alterità e si nutre di romfobia, neologismo che ben esprime questo distacco da una cultura della cui arte, storia, capacità narrativa non si sa nulla ma di cui si pretende di sapere tutto.
L’incontro finisce lasciando una gran voglia di conoscere quello che le parole di Santino hanno solo introdotto.