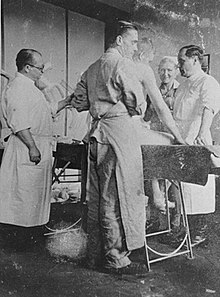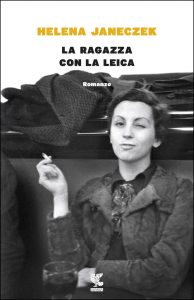Con l’aiuto di un cartone animato si riesce a parlare anche di aberrazioni dell’umanità senza far perno sull’orrore, questo era l’obiettivo dell’incontro con Andra e Tatiana Bucci, le più giovani sopravvissute italiane di Auschwitz, organizzato con l’aiuto del staff dell’Istituto Cipriani di Adria per i ragazzi della scuola superiore. Con la pacata signorilità che le due signore riescono a dare al loro racconto siamo riusciti a trasmettere a ragazzi, particolarmente attenti, alcuni importanti elementi della vicenda personale delle sorelle Bucci ma anche un quadro generale della persecuzione degli ebrei italiani. La Shoah ha colpito ebrei italiani, anche frutto di matrimoni misti come Andra e Tatiana che avrebbero potuto essere risparmiate se il clima di violenza e la collaborazione con i nazisti, specie nelle zone di confine, non fosse stato così aspro e duro. La violenza, l’odio, il profitto legato ai tradimenti era tale che non dovrebbero stupire gli esiti successivi nel corso e alla fine della guerra. I ricordi di Andra e Tati che avevano 4 e 6 anni al momento della loro cattura, sono quelli frammentari di bambine piccolissime che si adattavano ad ogni cambiamento, senza capire e pensare alle conseguenze. La loro esperienza passava dal gioco attorno ai cadaveri, alle attenzioni della blokova, all’apprendimento di lingue diverse in rapida successione. Una tempesta fisica, mentale e d emotiva che per fortuna nei bambini lascia spazio alla resilienza, ossia alla capacità del loro essere di ritornare, come una spugna dopo esser stata spremuta, allo stato iniziale.

I ragazzi hanno ascoltato in silenzio e hanno poi fatto le loro domande. Il messaggio che speriamo sia passato è stato l’appello delle più giovani sopravvissute ad Auschwitz a non odiare l’altro, a saper fare distinzione tra il bene e il male. Ci sono sempre meno sopravvissuti a testimoniare per questo Andra e Tatiana si sentono spinte a continuare a farlo nonostante la fatica. Piccole ebree deportate ma anche esuli delle terre Giuliano-dalmate con nostalgia ma senza voglia di revanche e di riconquista.
Il viaggio è la testimonianza sono difficili e dolorosi ma doverosi. Alla domanda di una docente su come lavorare con gli studenti per renderli più consapevoli, Tatiana risponde con l’invito a farli ragionare e discutere, cosa che dovrebbero fare le famiglie oltre che la scuola. Sul tema della migrazione Tatiana ha sottolineato che la situazione è diversa ma l’analogia sta nell’atteggiamento di indifferenza verso chi cerca una vita migliore o la fuga dalle sofferenze. Anche Andra e Tati sono state profughe e addirittura in Italia, quando scelsero l’Italia al posto della Jugoslavia, e non ricordano un bel clima anche se erano italiane e di pelle bianca.