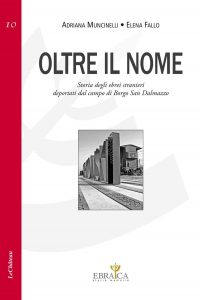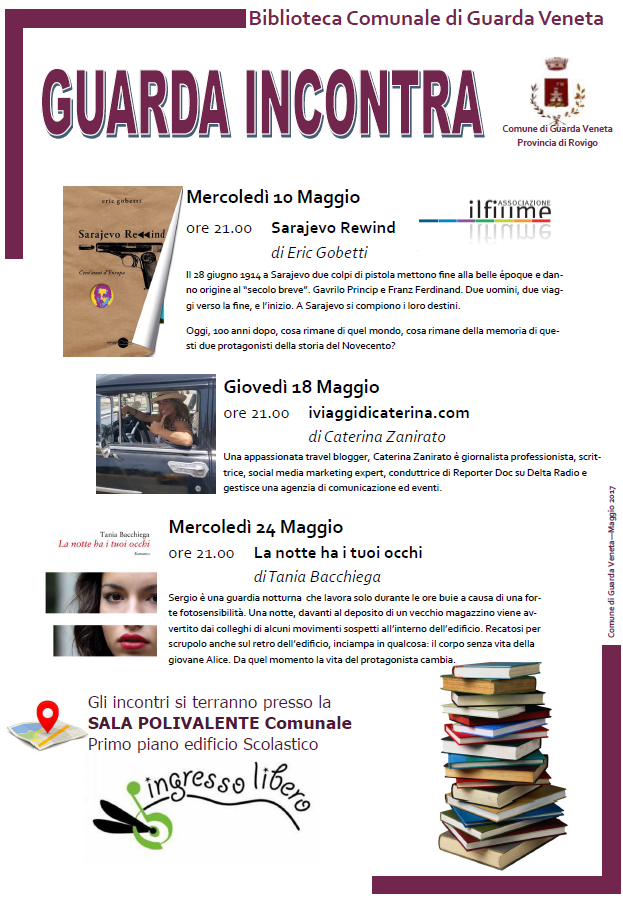All’esame di maturità mi toccò in sorte il greco come seconda prova e in particolare la versione presa dal testo “La Politica” di Aristotele che titolava “l’uomo è animale politico” , per questo e forse anche per l’esito non proprio felice della traduzione dal greco, la definizione mi è rimasta impressa. Marzo 2018 è stato il mese delle elezioni politiche e la politica riguarda la nostra vita quotidiana, investe il nostro impegno culturale, determina l’indirizzo della nostra istruzione, condiziona le scelte del tempo libero e quindi non fare politica è come non –vivere.
L’esito del voto ha premiato le forze di centro-destra, poco male, nella dialettica politica ci sta l’alternanza, ma quel che preoccupa è che entro queste forze sono confluite con regolari formazioni, simboli e programmi le forze che si ispirano al fascismo. Come è stato possibile nonostante una Costituzione, difesa ad oltranza nell’ultimo referendum da una strana accoppiata destra-sinistra estrema, che esplicitamente vieta la ricostituzione del partito fascista o di partiti ad esso ispirati? Non lo so.
Accanto alla destra un Movimento 5 Stelle, nato come rottura, al grido simbolico di “vaff..” ha preso un terzo dei voti e con l’euforia di chi non ha niente da perdere ma tutto da conquistare, nonostante le prove al di sotto della sufficienza dei suoi sindaci finora eletti, si propone alla guida del paese.
La Sinistra “…che parla sempre di tasse e di regole e con la sua petulante ossessione per la cultura, la sinistra mai semplice, mai alla mano…” come scrive il noto commentatore Michele Serra, non è utile al nostro paese, anche e forse perché nella sua ultima versione pur provando ad uniformarsi a certo pensiero economico di destra non ha convinto quasi nessuno.
Ora la formazione del Governo è affidata all’unione delle due forze politiche, apparentemente opposte, che hanno ottenuto la maggioranza. A Roma, nei giorni dell’euforia, è apparso un murales che mostra i due leader uniti da un bacio appassionato, non il bacio di Giuda, ma proprio un bacio appassionato.
Un murales accanto a quello con una Giorgia Meloni anti-migranti con un bel negretto in braccio. Bei murales molto ironici che sono stati subito cancellati … con la destra non si scherza! Peccato che, nell’era dei social la foto di questi murales abbia fatto il giro del mondo e rimarrà ad imperitura memoria e ad emblema della politica da ora in poi.
Una politica di cambiamenti repentini, di coincidenza degli opposti per opposti motivi, detta fatta e cancellata subito dopo, messa in streaming al bisogno e chiusa nelle segrete stanze all’occorrenza. Una politica senza partiti ma con società finanziarie alle spalle che accumulano somme enormi e gestiscono dati di milioni di persone che li affidano allegramente per poi lagnarsene subito dopo.
E’ comprensibile l’entusiasmo dei tanti giovani del Movimento 5 Stelle, che non avrebbero avuto nessuna possibilità in partiti tradizionali dove si richiedevano impegno a indire riunioni, trovare le sedi, affiggere manifesti, organizzare feste di finanziamento, mentre ora da casa con un clic al pc riescono a catapultarsi a Roma.
E’ comprensibile l’inebriante senso di “finalmente è possibile”, e che arrivare allo scopo prefisso si può passar sopra a quanto detto, scritto, giurato e spergiurato. Speriamo solo che l’incoerenza e il vendere la dignità porti a qualche beneficio che non siano quattro soldi promessi per calmare masse senza speranza.
Speriamo di poter avere un paese più civile, più onesto, in cui le risorse siano distribuite equamente e le opere pubbliche realizzate se servono al paese non ai magnati delocalizzati. Speriamo che ci daranno un paese senza campi di concentramento per migranti, senza omicidi per mafia o senza spaccio di droga, in cui la crescita sia coniugata con il rispetto dell’ambiente e l’ecologia.
Ovviamente non c’è da aspettarselo dalla destra scompatta tutto questo, ma dal Movimento 5 Stelle si. Datecelo, ne avete i numeri e il mandato!